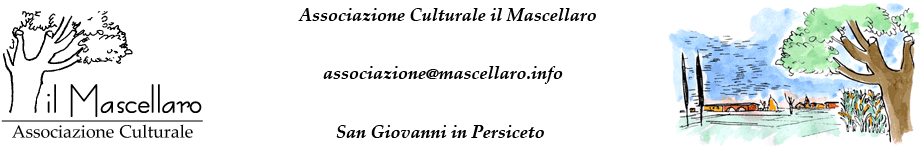o2 - L’inverno 1942 nell’impero dei Soviet: accerchiati dall’Armata Rossa
Tags:
 Per sfuggire al presente, la mente ed il cuore del vecchio celoviek bersagliere si tuffano nel passato e si ritrovano nel bel mezzo dell’anno 1941, dopo Cristo. In quel tempo, il bersagliere non ancora celoviek, tolto dall’università di Venezia fu spedito a Bolzano presso il 7° Reggimento Bersaglieri, poi inviato alla Scuola Allievi Ufficiali di Pola e, terminato il corso, spedito a Lodi, poi a Milano e assegnato al più bel reggimento d’Italia, il 3° Reggimento Bersaglieri, appunto. Assegnato al XVIII Battaglione Complementi di stanza a Besozzo, completò la preparazione militare a Portovaltravaglia, a Cavalese e infine ritornò a Milano da dove, come volontario comandato, si accinse a partire per il fronte russo dove l’Armir teneva alto l’onore dell’esercito italiano e difendeva i sacri voleri e gli alti destini della Patria.
Per sfuggire al presente, la mente ed il cuore del vecchio celoviek bersagliere si tuffano nel passato e si ritrovano nel bel mezzo dell’anno 1941, dopo Cristo. In quel tempo, il bersagliere non ancora celoviek, tolto dall’università di Venezia fu spedito a Bolzano presso il 7° Reggimento Bersaglieri, poi inviato alla Scuola Allievi Ufficiali di Pola e, terminato il corso, spedito a Lodi, poi a Milano e assegnato al più bel reggimento d’Italia, il 3° Reggimento Bersaglieri, appunto. Assegnato al XVIII Battaglione Complementi di stanza a Besozzo, completò la preparazione militare a Portovaltravaglia, a Cavalese e infine ritornò a Milano da dove, come volontario comandato, si accinse a partire per il fronte russo dove l’Armir teneva alto l’onore dell’esercito italiano e difendeva i sacri voleri e gli alti destini della Patria.Un saluto e un abbraccio frettoloso alla famiglia, uno sguardo fugace ai monti natali, un pensiero a una ragazza e agli amici e poi via, in fretta, ligio all’ordine dell’Autorità costituita. La tradotta militare, salutata alla stazione di Milano da una folla immensa, festante e dolorante insieme, di parenti, amici, rappresentanti di questo, di quello e degli altri, tra lacrime, sorrisi, baci, abbracci, canzoni e uno sventolio di bandiere, il tutto più da sagra folkloristica paesana che cerimonia di saluto, s’avviò lentamente prima, poi sempre più veloce verso i nostri confini e oltre. Attraversò paesi, città, nazioni, popoli sconosciuti e dopo tanti giorni di viaggio raggiunse il 3° Reggimento Bersaglieri che stava combattendo sul fronte del placido Don.
Il ricordo corre veloce nel cuore dell’Ucraina, passa oltre Serafimovic e Stalino, attraversa il bacino del Donez e si ferma a Sagrabelovka, piccolo paese sperduto nella steppa infinita vicino al mitico, sacro fiume osannato da poeti e scrittori, il placido Don, dove parte del 3° Reggimento sta concedendosi qualche giorno di meritato riposo dopo le cruente battaglie di recente sopportate.
I bersaglieri sono accantonati in baracche, in rari edifici in muratura, soprattutto nelle isbe5; le sentinelle, i posti di blocco, le pattuglie vigilano e salvaguardano il loro meritato riposo. Di giorno si puliscono, si oliano, si controllano le armi e l’efficienza dei motori; alcune esercitazioni ed esercizi fisici conservano la preparazione militare e la salute del corpo. Contatti saltuari con qualche tovarisc russo, parecchie partite a carte, molti racconti d’imprese amorose e buon umore condito con allegria e ironia occupano la giornata.
Quanti corpetti grigioverdi passano furtivamente, durante le fugaci e sospettose passeggiate lungo il viale ripieno di buche e di fango che attraversa per il lungo tutto il paese, dal corpo dei fanti piumati a quello più piccolo dei malenchi russi o di vecchie babuske, le care nonne di ovunque. Sono questi atti, i risultati delle pubbliche relazioni tra i fascisti banditi invasori e la popolazione nemica, per la verità brava e povera gente! Anche parecchie occhiate lanciate di sottecchi verso alcune ragazzotte russe - gli ordini in merito erano severi -, belle in faccia ma col corpo incartato nei loro caratteristici indumenti invernali, le fufaike, goffi senz’altro ma utili contro il freddo, soddisfacevano alla meglio desideri comuni a giovani ventenni. A quelle rappresentanti del gentil sesso poi, era inutile guardare le gambe perché dove terminavano le rare sottane iniziavano i valenki (stivali di feltro) e quasi tutte indossavano i pantaloni, anch’essi imbottiti come le giacche. Nemmeno con l’immaginazione più fertile riuscivamo a dar adeguata e reale forma alle parti anatomiche del corpo femminile più desiderate. Sembravano vestite con le doghe di un barile.
Quando l’aria imbruna e scendono le prime ombre della sera, al suono d’improvvisate orchestrine familiari composte da qualche organino a bocca, una scassata balalaika, tanti coperchi delle gavette e gavettini pure, cucchiai e coltelli in quantità, s’odono dintorno, qua e là, cori, ritmi, motivi di nostre care, vecchie canzoni: Tu che mi sorridi, verde luna…… Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle…… O mia bela Madunina, che te brillet de luntan…… Tutte le sere sotto quel fanal... Lilì Marlen…… ‘O sole mio, sta ‘nfronte a te…… Mamma son tanto felice…… Paola mia rondinella, sei la più bella……
Quante lettere vengono scritte alle famiglie lontane in questi giorni di quiete, di pace! Voglia Iddio che non siano le ultime a partire; lo speriamo tutti.
Sagrabelovka: un paese sperduto nell’immensa Russia, uguale a tutti gli altri paesi e diverso solo nel nome; una lunga via in terra battuta, lastricata di buche e di fango, cinta da due file di isbe, una cinquantina in tutto; qualche albero sparso qua e là; il solito pozzo col parapetto di tronchi; una vecchia chiesa in muratura con l’intonaco sbrecciato e segnato dall’incuria e dagli anni, trasformata come vuole la dottrina comunista in magazzino; qualche raro edificio in mattoni e poi topi, topi dappertutto, migliaia, anzi milioni di topolini campagnoli affamati come tutti i non topi. Nelle vicinanze del paese, d’intorno e fino all’orizzonte, la steppa, brulla e piatta, che termina confondendosi col cielo nebbioso. La vita che scorre non è certo comoda o brillante ma pur sempre bella e desiderabile.
Il celoviek bersagliere (c.b.), dopo tre o quattro giorni con un febbrone da cavallo, viene ricoverato all’ospedaletto da campo che è ubicato in un decente capannone. Sembra tifo o paratifo, dicono i medici. Non è vero, infatti dopo un paio di giorni la febbre di colpo sparisce e il c.b. torna tra i suoi bersaglieri:
“Bentornato tenente; niente convalescenza a Millerovo o più in là?”
“Niente di niente; noi del Terzo siam ritenuti immortali e quindi: via c’as và”.
Le notizie che ci giungono in questi giorni dal fronte non sono delle migliori; si dice in giro che i russi attacchino forte sui settori di fronte delle Divisioni Ravenna e Pasubio. Siamo a metà novembre dell’anno 1942. Di giorno si odono in lontananza, anche se ovattati, i rombi dei cannoni di grosso calibro e gli scoppi dei proiettili; di sera il buio è squarciato da lampi fugaci e continui. È certo che non ci troviamo in una notte di mezza estate coi lampi del caldo afoso o in qualche vicinanza di una festa paesana dove non mancano mai i fantasmagorici fuochi artificiali; no, no, sono soltanto echi di battaglie lontane. Gli aerei nemici non ci disturbano affatto; mai vista l’ombra dei soldati fantasmi, i partigiani. D’altronde cosa possiamo temere dai civili tra i quali viviamo? Niente perché “italianski carasciò” (buoni italiani), dicono di noi. Da est, circa le nove, alle ventuno suppergiù, di ogni sera arriva ad augurarci la buonanotte quel coso, su nel cielo, che i bersaglieri hanno battezzato la motocicletta. È un piccolo aereo che volteggia due o tre volte sopra il paese, corre ben alto lungo la fila delle isbe, sgancia a casaccio qualche spezzone, fiuta dabbasso e poi riparte, poi più niente.
Gli attacchi russi contro le nostre divisioni schierate nell’ansa del Don aumentano di giorno in giorno d’intensità e poi si spostano sull’Armata romena che dopo una certa resistenza abbandona il fronte ritirandosi disordinatamente. Presto tutta l’Armata romena è in fuga; che disastro! Le brutte notizie non giungono sole; il comando della nostra divisione ci fa sapere che i russi, lungo la linea abbandonata dai romeni, irrompono ad ovest, puntando a sud verso Stalingrado e anche a nord. Le divisioni: Sforzesca, 112a tedesca, Celere, Torino, Pasubio, Ravenna, Vicenza, il Raggruppamento CC.NN.6 e, più a nord, il Corpo d’Armata Alpino (Cosseria, Tridentina, Julia), schierati sul Don non sono stati ancora investiti dal massiccio attacco del nemico e si trovano assestati saldamente sulle linee di difesa, ma è chiaro che nella breccia apertasi nel tratto di fronte abbandonato dai romeni irrompono le divisioni corazzate dei russi e con esse il pericolo di accerchiamento della nostra intera armata si fa sempre più temibile.
Il tempo è nebbioso e piovoso, il freddo in questi ultimi giorni di novembre comincia a farsi sentire; scende anche la prima neve che subito non è più neve ma tormenta, gelo. La tromba suona il rapporto ufficiali; forse sta per finire il dolce riposo.
Signori ufficiali, attenti; inizia il rapporto:
“Poche, brevi, dure parole, ma chiare: la situazione strategico-militare delle nostre divisioni, illustratavi alcuni giorni orsono, ha assunto ora una veloce piega degradante verso un punto che posso definire grave. La 112a Divisione tedesca, che occupava e teneva saldamente il settore di fronte ubicato tra quello della Sforzesca e della Torino, lascerà questa notte, alle ore tre, la linea sulla quale è attestata per recarsi altrove poiché in seguito allo sguarnimento del tratto affidato ai romeni, l’ala sinistra dello schieramento tedesco a Stalingrado e tutti i rifornimenti che in quel luogo d’inferno affluiscono sono in serio pericolo di accerchiamento e d’interruzione. Tenterà la 112a Divisione di contenere, in attesa di rinforzi, l’avanzata dei russi o per lo meno l’ampliamento, soprattutto in profondità, di quella testa di ponte, fonte di mortale pericolo anche per le nostre divisioni. Il 3° Reggimento Bersaglieri, poi il 6°, daranno questa notte il cambio ai combattenti tedeschi che partono per altra zona. Alle ore diciotto precise, il nostro reparto, in ordine con gli effettivi, con le armi, coi viveri e con le munizioni partirà per raggiungere la nuova linea del fuoco. Gli autocarri trasporteranno gli uomini il più vicino possibile alla meta. Tra un’ora esatta, gli ufficiali che ora elencherò mi accompagneranno, assieme ad un ufficiale tedesco di collegamento già giunto, a visitare il settore di fronte assegnatoci per meglio effettuare il cambio dei reparti. I comandanti di compagnia riceveranno gli ordini di marcia, le indicazioni per le indispensabili misure di sicurezza, l’itinerario da seguire; tali disposizioni verranno trasmesse dai comandanti di plotone alla truppa non appena ci muoveremo dal paese. Ci sono domande in merito? Nessuna? Allora buona fortuna a tutti e in alto i cuori, siamo del Terzo”, conclude il comandante.
Ore 15. È finito il rapporto ufficiali e tutti ritornano in silenzio, senza troppi commenti e con poca apprensione in cuore, ai propri reparti.
Ore 16. Hanno inizio i preparativi per la marcia di avvicinamento al fronte. Come a ridestare la dolce e apparente quiete che sovrasta il paese di Sagrabelovka, sperduto nella infinita steppa oramai bianca e ghiacciata; quasi a richiamare alla cruda realtà le menti e i cuori di tutti noi, vaganti fino a poco fa nelle immensità senza confini e irraggiungibili dell’illusione, popolata dai sogni più belli e dalle ombre più care rievocate nel dolce far niente del breve riposo, ecco, d’improvviso, simile al brontolio del tuono che annuncia un temporale estivo, il rombo possente dei motori dei nostri autocarri che gli autieri, con rapide accelerate verificano e controllano. Col loro carico di armi e di viveri, in attesa dei bersaglieri, corrono qua e là veloci e saltellanti sulla pista piena di buche e di pozze ghiacciate; appaiono e scompaiono ma tutti si fanno sentire e vanno, accompagnati da un turbinio di polvere, di neve o di terra. Si fermano con una brusca frenata, ripartono spinti da una solenne sgasata poi si riposano, contenti. Ramoscelli rinsecchiti, fissati ai grigioverdi tendoni, tentano di mimetizzarli ad occhi curiosi e indiscreti; un cerchietto tricolore nella carrozzeria indica ad amici e conoscenti una vecchia ferita; un piumetto da bersagliere sul tappo del cofano l’appartenenza al Terzo. Questi i nostri autocarri. Gli girano davanti e dintorno, con sbandate paurose e folli scivolate, le motociclette Guzzi e Gilera: anch’esse fanno parte del nostro reggimento; anche loro vanno.
Ritorna il silenzio. Ore 17. Viene distribuito il rancio che in breve è consumato. La canzone suonata dall’orchestra dei motori non s’ode più; anche il brusio e il vociferare caratteristici di gente in attesa è cessato e le note di qualche nostra marcetta bersaglieresca si perdono con una folata di vento. Nessun cucchiaio tamburella nella gavetta ormai vuota. È silenzio; dappertutto silenzio, nel paese e nella steppa, in cielo e in noi. I reparti sono vicini ai rispettivi autocarri. Mancano pochi minuti alla partenza.
Ore 18, via. Un rombo, un fremito di motori e i motociclisti mitraglieri aprono la marcia seguiti dalla lunga colonna che avanza. Alla testa, mi par di ricordare, il XXV Battaglione, poi il XX, il Comando e le salmerie, la Sanità e il XVIII come retroguardia. Avanti, Ad maiora viribus audere7 è il messaggio che a molti par di sentire tra le sferzate del freddo marosc che non ci vuole lasciare partire. Sulle piste desolate e deserte, attraverso lo squallido e monotono paesaggio russo già ricoperto da qualche spruzzata di falde di neve ghiacciata e spazzato dalla tormenta che viene dal nord, passa e corre il 3° Reggimento Bersaglieri con alla testa la sua gloriosa bandiera; marcia e va ancora una volta verso la sua ennesima battaglia, non verso la sua ultima gloria.
Veloci e saettanti motociclisti proteggono anche i lati della colonna da eventuali attacchi di pattuglie nemiche; i portaordini tengono i collegamenti fra i vari reparti che avanzano. La marcia di avvicinamento, dopo molte ore, si conclude senza incidente alcuno; gli aerei nemici non ci hanno dato fastidio e l’artigieria russa ci consente di giungere fin quasi nei pressi della linea del fronte, a ridosso dello storico fiume: il placido Don.
Si scende dai mezzi e ogni reparto cerca di raggiungere la zona assegnatagli mentre i tedeschi iniziano a ritirarsi sparendo nel buio delle tenebre fitte. Che bufera stanotte! Quel maledetto dio dei venti ci sbatte in faccia manciate di fiocchi gelati che paiono spilli. Il termometro che ciascuno di noi si porta dietro per dono della natura, le palpebre degli occhi, ci segnala che la temperatura non è ancora scesa sotto i trenta gradi; infatti oltre tale segno le palpebre si appiccicano tra loro; le nostre sono ancora libere di sbattere a piacimento. Comunque il freddo è già tanto pungente.
Il silenzio che grava dintorno è rotto a intervalli aritmici dal cupo, lontano rimbombo di un colpo d’artiglieria; non manca ogni tanto anche il flebile gracidare di una pettegola mitragliatrice che arriva portato da una folata di vento, mentre vicino s’ode ogni tanto il lugubre ululare di un lupo affamato o forse in amore. Alle tre termina il cambio con gli ultimi reparti tedeschi che se ne vanno; qualche stretta di mano, un arrivederci e un auf wiedersehen, poi più niente.
Riprende la non piacevole vita di trincea. Ora tutto il reggimento è attestato sulla riva destra del grande fiume: al suo fianco sinistro la Legione croata, i fanti della Divisione Torino, all’altro i bersaglieri del Sesto.
L’alba grigia del giorno che nasce, il 16 di novembre, su quel tratto di fronte tenuto dai soldati tedeschi, vede ora garrire al vento il nostro tricolore difeso dai fanti piumati d’Italia. Il XVIII Battaglione è sistemato a difesa alla periferia di un piccolo, solito paesino russo: Migulinskaja. A ridosso della linea di trincea si estende una larga balka8; in avanti, a poche centinaia di metri che in alcuni tratti si riducono a una decina, scorre il placido Don. Le sue acque si muovono così lentamente da farle sembrare quelle di un lago e nessuno riesce a distinguere il corso della corrente. Una piccola boscaglia con alte, bianche betulle e molte sterpaglie ricopre il tratto di terreno fra noi, il Don e i Russi.
Quello spazio è terra di nessuno; di giorno, e ancor più di notte, è patrimonio delle pattuglie di entrambi gli schieramenti che scorrazzano in lungo e in largo alla ricerca di notizie sui movimenti, la dislocazione dei reparti e delle postazioni, le difese dell’avversario. Oltre a questo, per noi è d’importanza vitale accertare che il nemico non oltrepassi il fiume per costituire sulla riva destra una testa di ponte dalla quale sferrare un attacco alle nostre linee. L’obiettivo secondario del pattugliamento è quello di poter sopraffare una pattuglia non tanto per uccidere qualcuno, ma per catturare qualche prigioniero per saperne di più. Quando due pattuglie avversarie si scontrano, se è notte, si accendono improvvise e guizzanti mille fiammelle e poi, come le faville dei fuochi, a poco a poco si spengono; se è giorno, in genere, si odono vicini e distinti i colpi dei mitra, dei fucili e gli scoppi delle bombe a mano, poi più niente; difficilmente si riescono a vedere i protagonisti dello scontro. Spesso però non mancano urla di dolore dei feriti o i silenzi più cupi della morte.
Due capisaldi avanzati, uno di fronte al tratto di linea tenuto dal XVIII Battaglione e uno davanti al Venticinquesimo, costruiti sulla terra di nessuno, danno maggior sicurezza ai bersaglieri che vivono nelle trincee. Il grande fiume non è ancora gelato; le sue acque giallognole, che non si riesce a capire verso quale direzione scorrano, sembrano la piatta distesa di un lago d’olio uscito da un grande frantoio. Quelle acque ignorano tutto e tutti. Per conoscere con certezza dove si trovino sorgente o foce, stando ben nascosti dietro qualche grossa berioska9 perché i russi, non appena intravedono qualcosa muoversi o qualcuno, peggio ancora, sparano dappertutto e senza economia di colpi, bisogna gettare un pezzo di legno nell’acqua e vicino alla riva. A sinistra del nostro battaglione è schierato il Ventesimo; alcuni tratti delle sue linee sono così vicine a quelle russe che i nostri odono il loro vociare e viceversa. Oltre il Ventesimo sono assestati la Legione croata e il 4° Reggimento Fanteria della Divisione Torino. Alla nostra destra invece abbiamo il XXV Battaglione, sempre del Terzo che si collega col XIII Battaglione del 6° Reggimento Bersaglieri, al quale fa seguito il 54° Reggimento Fanteria della Divisione Sforzesca.
I Russi sono fortificati sulla riva opposta del Don. Si vedono in lontananza, anche senza il cannocchiale, le varie linee di trincee che fanno parte del loro sistema difensivo. Spesso udiamo, portati dal vento, lo sferragliare dei pesanti T-3410 e il rombo dei motori degli autocarri che probabilmente dalle retrovie fanno affluire rinforzi ai loro combattenti al fronte. Il Comando della Divisione Celere (3° e 6° Reggimento Bersaglieri, 120° Artiglieria) si trova a Millerovo; quello di Reggimento (3°) a Miklin; del XVIII Battaglione a duecento metri circa dalla linea del fuoco, a ridosso della balka, in un bunker scavato in un crepaccio del terreno, ben mimetizzato, difficile da individuare. Sui rari cartelli che indicano la via per il Comando di battaglione c’è disegnato un fiore: una rosa con grosse spine. Comanda il battaglione il Capitano Spinosa, un soldato eroico e amato dai suoi ufficiali.
Il Comando della nostra compagnia, ubicato a pochi passi dalla linea del fuoco in una cantina di una casa diroccata, ha anch’esso, sul cartello indicatore, il suo emblema. Un poco buffo in verità, ma simpatico e che fa tenerezza. Ricorda, a chi lo guarda, la spensierata età della fanciullezza così ormai irrimediabilmente lontana e le belle e forse uniche letture, a quei tempi, di un giornalino, il Corriere dei Piccoli, riservato a pochi, privilegiati ragazzi. Infatti una grossa mula, la Checca, che scalcia e manda al di là di un fiume un mugiko col colbacco in testa, Ciccio, appare sul cartello che indica il Comando della 2a Compagnia; il branco, come molti la chiamano dei più folli bersaglieri del XVIII Battaglione del Terzo. Comanda questo reparto il bravo e mai dimenticato capitano Checchini del quale, dopo l’assalto alla piazzaforte di Meskov, mai più nulla ho saputo.
Bunker spaziosi e ben protetti, scavati a vari metri dal suolo, riscaldati da piccole ma meravigliose stufette accolgono i bersaglieri nelle ore di riposo. La linea del fronte è ben munita: depositi sotterranei per viveri e munizioni; alcuni sbarramenti di mine anticarro e antiuomo; due capisaldi avanzati; postazioni fisse per armi automatiche; reticolati, trincee, camminamenti e su un tratto anche un fosso anticarro completano le difese.
Quel benedetto fosso, o maledetto, chissà, in parte naturale e in parte scavato che costituiva una modesta difesa contro i pesanti carri armati dei russi, i T-34, per poco non diventava la mia fossa. Si snodava su un tratto di terreno pianeggiante e brullo distante dalla nostra trincea una ottantina di passi; era profondo un paio di metri scarsi, largo quattro. Una difesa discreta, non insuperabile per quei mostri d’acciaio che pesavano trentaquattro tonnellate. Solo gli 88 tedeschi, superbi cannoni contro i carri, erano i mattatori di quei bestioni corazzati11. Le nostre mitragliatrici e i mitragliatori, compresa la stupenda Breda 37, a mala pena riuscivano a graffiare quelle pesanti lastre di acciaio; le bombe a mano, se proprio riuscivamo a farle scoppiare sui cingoli, qualche volta arrestavano la corsa di quei mezzi. Un risultato migliore si otteneva lanciando contro il carro barattoli di benzina ai quali venivano legate delle bombe tipo Breda, Srcm, Oto Melara, le quali, esplodendo, avvolgevano per qualche minuto quei mostri in una vampata di fuoco, spesso disastrosa per i ben protetti carristi. In diverse occasioni, quando ad attaccare le nostre posizioni venivano lanciati parecchi mezzi blindati o corazzati, i bersaglieri, nascosti in buche profonde e strette, riuscivano ad attaccare sotto il ventre di quei bestioni delle mine anticarro che ne decretavano quasi sempre la morte. Non era raro il caso, poi, che alcuni bersaglieri, sempre acquattati in buche adeguate per difesa ed offesa, riuscissero a salire, defilati dalle mitragliere di bordo, sul carro e ad infilare in qualche feritoia una bomba; era la fine del carro e dei suoi occupanti.
Vicino al fossato, durante un giro d’ispezione avevo intravisto una pesante lastra di acciaio con una stretta apertura al centro, residuato bellico, forse, ma anche preziosa difesa per una nostra postazione di mitragliatrice protetta o da sacchetti di sabbia o da tronchi d’albero. Deciso a recuperarla, visto che di giorno in giorno aspettavamo l’attacco massiccio delle truppe russe e quindi dedicavamo molto tempo a migliorare con tutta la buona volontà e con ciò che l’ambiente ci offriva le nostre protezioni, m’incamminai col sergente Cappellaro e col fido Aleci, guardinghi e nascosti il più possibile a sguardi indiscreti, sul breve tratto pianeggiante che ci separava dal fossato. Tutto liscio, nessun intoppo di sorta. Entrati nel fosso, e quindi occultati alla vista di amici e nemici, ci portammo vicino al luogo dove era stata abbandonata quell’ambita lastra di acciaio. Risaliti sul terreno pianeggiante dove, a circa una decina di metri giaceva il residuato, visto che attorno non si vedeva anima viva e le trincee russe distavano un buon centinaio di metri, a carponi riuscimmo ad afferrare la preda bellica e con un tonfo a gettarla nel fossato da dove in tutta tranquillità l’avremmo trasportata a destinazione.
Considerata la misura di sicurezza che mi separava dal nemico e la pace che ci circondava, prima di scendere nel fossato decisi, ormai che ero lì, di dare col cannocchiale una sbirciata oltre il fiume. Ad un tratto un guizzo di sibilo mi saetta all’orecchio come se qualcuno mi avesse fatto cenno con un dito sul naso di zittire. Non ho nemmeno il tempo di pensare a cosa possa essere stato quel fulmineo soffio che un altro, più basso, mi scuote e sollevando uno spruzzo di terra o di neve ghiacciata si perde a pochi passi da me. Ho capito, esclamai tuffandomi nel fossato! Curiosare non è educato; dimenticarsi porta male, anzi peggio; infatti non ricordavo che i russi avevano in dotazione degli ottimi fucili col cannocchiale che, affidati a tiratori scelti, a cento metri spesso facevano centro, o quasi.
L’artiglieria della Celere, il 120° Reggimento comandato dal colonnello De Simone12, ha preso posizione dietro le nostre linee; infatti sentiamo sulle nostre teste il sibilo di alcuni proiettili che hanno lo scopo di aggiustare il tiro su eventuali probabili bersagli da battere in caso di attacco in forze dei russi.
Benché la situazione sia grave ci sentiamo stranamente sicuri e tranquilli.
“Dovranno passare di qui”, mormorano in molti.
“Ci sarà da ridere, e per chi tenterà da piangere”, dicono altri. La vita è fatta anche di illusioni; e senza illusioni che triste il vivere!
Brevi scaramucce e colpi di mano da entrambe le parti; sporadici duelli di artiglieria; intensa attività di pattuglie specialmente di notte; alcuni colpi messi a segno dai tiratori scelti russi nella postazione più avanzata del XX Battaglione, nel punto in cui le due linee quasi si toccano, caratterizzano l’apparente calma, meglio la snervante attesa di questi giorni brevi di luce ma lunghi nel trascorrere.
Ci sono venuti a trovare alcuni aerei e non il solito corvo ricognitore o le cinque sorelle Dionne13; una vera formazione e in diverse ondate. Pochi i danni agli uomini e alle cose. Tre case, cioè tre isbe bruciano nel paese; un bagliore rossastro illumina gli scheletri nudi e ghiacciati di altre bicocche semidiroccate. A destra, a sinistra, in lontananza ogni tanto squarci di lampi infuocati illuminano il buio; miriadi di scintille, con sinistri scoppiettii, lambiscono le basse, pumblee nubi in cielo; steli roventi di traccianti s’alzano guizzanti verso quegli uccelli rapaci che non si vedono ma si sentono volare. Dopo i lampi i tuoni; colpi secchi o prolungati, come un brontolio di giganti, or radi e più tenui ma pur sempre rimbombi che t’entrano in corpo, ti scuotono e ti raggelano molto più del marosc. Apocalittica visione di un bombardamento notturno.
Stamani è successo qualcosa da raccontare ai nipoti. Gli uomini addetti alle salmerie hanno prelevato dal magazzino, come di solito, i viveri e i generi di conforto tra i quali anche il vino, che è arrivato in trincea non nei soliti recipienti ma in sacchi e in grossi blocchi gelati. Probabilmente il freddo è già tanto ma per la verità non ce ne siamo accorti. Qualche lingua cattiva d’intenditore enologo dice che il fenomeno non è imputabile al freddo ma ai pochi gradi dell’alcool e alla troppa acqua piovana caduta nei giorni passati.
Sono d’ispezione stanotte alla linea tenuta dalla 2a Compagnia. Più che il freddo dà noia il buio ch’è sempre più buio. Anche se i camminamenti, le postazioni, i bunker ci sono arcinoti, quel maledetto buio profondo urta i nervi e ti nasconde ogni cosa mentre ti nasce l’impressione di vedere dintorno cose, persone, ombre che in realtà non esistono affatto. Scherzi del buio o scherzi dei nervi fin troppo tesi e ormai già stanchi? Chissà! Entro nella postazione che ha di fronte il caposaldo avanzato distante un centinaio di metri; mi segue il fido Aleci, il mio attendente. È un bersagliere abruzzese, un giovane in gamba che non conosce paura alcuna. Dall’assalto alla chiesa di Meskov mai più l’ho rivisto; lo ricordo però e mai lo scorderò perché era un uomo, un uomo vero, uno dei tanti umili e sconosciuti eroi che nessuno mai ricorderà. Il Signore, se esiste, sì. Il puntatore, gli occhi sbarrati e fissi in avanti come se volessero squarciare le tenebre, con la fronte appoggiata alla feritoia, una mano sulla canna della fedele Breda 37, l’altra sull’impugnatura dell’arma col pollice sul bottone-grilletto, forse è l’unico dei cinque bersaglieri che ha notato il bombardamento notturno. Gli altri quattro, seduti e col fucile tra le mani si stanno raccontando le ormai lontane avventure d’amore.
“Salve ragazzi, come va?”
“Bene, signor tenente, un poco freschino, niente altro.”
“Ci sono novità nelle vicinanze di questa tana?”
“No, ma già che è qui ce lo dà un consiglio, signor tenente?”
Chi parla è Birelli, un bersagliere dei più in gamba, un milanese (così mi par di ricordare o delle zone limitrofe) che poi ho visto cadere sotto il bombardamento dei mortai russi durante la marcia di avvicinamento alla chiesa di Meskov, dopo il paese di Kalmikov, e del quale ignoro la sorte. Tra le tante medaglie distribuite, più o meno meritate, Birelli ne aveva diritto ad una. Di lui ricorderò per sempre una cosa: quando dovevo uscire di pattuglia nella terra di nessuno, tra i volontari non mancava mai; se c’era un pericolo da affrontare lui non era mai secondo ad altri; durante gli assalti lo spelacchiato piumetto di Birelli mi era sempre vicino. Il Signore lo ricorderà certamente; gli ominidi no.
“Il consiglio che le chiediamo, signor tenente, è questo: quel polentone là dice che la sua ragazza gli ha scritto intimandogli di sposarla con urgenza perché lei è arcistufa di aspettare. L’ultimatum è giustificato dalla gran voglia di rivederlo e poi perché dopo cinque mesi non ce la fa più”.
“Balle”, interviene un altro, “è perché l’ha messa incinta prima di venire in Russia, signor tenente, altro che voglia di rivederlo.”
“Sta zitto tu, fesso meneghino”, rumiga un terzo.
“Se uno si sposa regolarmente, signor tenente, gliela danno la licenza?”
“E chi lo sa, gente! Tentare non nuoce, ma temo che le licenze siano di questi tempi, e chissà fino a quando, licenziate. Comunque spes ultima dea, quindi presenta la domanda, costa così poco. Ora ragazzi vi saluto e... occhio alle bombe ma soprattutto ai russi”.
Nelle trincee e nelle postazioni tutto è in ordine; nessuna novità di rilievo: buio, calma apparente, silenzio dovunque. Rientro nel bunker e mi accingo a sdraiarmi sul tavolaccio per un meritato riposino. Un piccolo trillo, la solita esclamazione di Aleci che ad ogni rottura di statica calma si rivolge alla “Coccia di santo Donato”, il protettore del suo paese e un: “Signorsì, signor capitano, glielo passo”, sono gli spiacevoli inconvenienti che ti tolgono il desiderato piacere di non pensare a nulla.
Ci risiamo! Devo raggiungere immediatamente il Comando della compagnia per ordini di servizio. Le notizie apprese dal comandante riempiono il cuore dei presenti al rapporto di tristezza e di rabbia. Durante il bombardamento aereo una postazione avanzata del XX Battaglione è stata attaccata di sorpresa dal nemico e tanta improvvisa e silenziosa è stata l’azione che sentinelle e vedette non hanno dato in tempo utile l’allarme. Pare che siano stati prelevati dai russi un sergente, due bersaglieri e un fucile mitragliatore. Sulla neve sono rimaste tracce di lotta e di sangue. Bisogna raddoppiare le sentinelle, intensificare la sorveglianza nelle trincee, organizzare pattuglie per controllare il terreno antistante e retrostante la linea sulla quale siamo attestati per scongiurare il ripetersi di simili fatti e per impedire che aviatori russi di un aereo abbattuto dalla nostra contraerea, durante il recente bombardamento, possano attraversare il Don e rientrare alle loro basi.
Stamani si è riaffacciato il sole, un sole pallido e freddo come la faccia di un morituro. Sempre sole, però; sempre bello. La temperatura sfiora i 25° sotto lo zero; il vino continua ad arrivare nei sacchi e i furieri lo dividono con l’accetta; tutto è strano in questo strano, immenso paese. Il cielo terso, sereno rende gli animi allegri e il morale alto; il riverbero della luce c’impedisce di guardare a lungo in un medesimo posto o uno stesso obiettivo; i cristalli di neve, a prima vista bianchi, opachi, smorti, privi di vita, colpiti da un raggio di sole diventano di colpo sfavillanti e guizzanti come le stelle lucenti nel cielo d’oriente, vivi.
I due aviatori russi caduti alcune sere fa nei pressi di Kalmikov sono stati catturati stamani all’alba in una isba abbandonata e semidiroccata alla periferia di Migulinskaja mentre, nascosti e vestiti con abiti civili, attendevano forse il momento propizio per attraversare le nostre linee e ritornarsene fra gli amici al di là del Don. Sì, scoperti e catturati con l’aiuto di un cane. Tra il III Plotone della 2a Compagnia e il Primo della Terza, a pochi passi dalla bicocca dove si erano nascosti, si trova la postazione di un nostro mortaio da 81. La postazione è scavata nella terra ed è collegata al bunker, dove sono sistemate le munizioni e alloggiati i bersaglieri addetti all’arma, da uno stretto camminamento. Solo la bocca del mortaio fuoriesce dal terreno e il tutto è mimetizzato così bene che nient’altro si vede da lontano o da vicino. Nei pressi della postazione, a qualche decina di metri di distanza, c’è una specie di capanno di frasche e rami secchi dove trovano rifugio e un poco di riparo dal gelido marosc il puntatore e la sentinella. Da quel posto sopraelevato di vedetta lo sguardo spazia dintorno, lontano e nasconde da occhi indiscreti. Un cane randagio, e nel paese ce ne sono diversi, probabilmente in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti, entrato in quell’avanzo di isba dalla parete diroccata, fiutati e poi visti quei due uomini rincantucciati in un angolo buio, ha cominciato ad abbaiare a lungo. La sentinella nel capanno, insospettita da quell’insolito e prolungato abbaiare dell’animale che entrava ed usciva più volte dalle macerie, avvertiva il capoposto il quale inviava due bersaglieri per conoscere il motivo dell’insolito comportamento di un cane affamato. Dopo poco i due aviatori con le mani alzate, seguiti dai bersaglieri coi fucili spianati e dal cane che continuava ad abbaiare forse più festante che arrabbiato, tranquillizzati e rifocillati venivano accompagnati al Comando di reggimento per essere interrogati. Da quel giorno il cane fece parte, si fa per dire, dell’organico della 1a Compagnia, mangiò e riposò nei nostri bunker.
Il tempo, anche se pare fermo, immutevole trascorre nel mondo coi ritmi che la natura gli ha assegnato. Da alcuni giorni più intenso e rabbioso si ode sulla destra del nostro schieramento, in lontananza, un sordo brontolio di tuono. Probabilmente artiglieria e katiuscia sono i principali strumenti di quel concerto infernale. Si mormora in giro che la battaglia divampi nei pressi delle sfondate linee dello schieramento romeno ormai in completa disfatta, da dove sciamano le forze corazzate e le divisioni di fanteria russe. Tra i secchi e numerosi boati delle bombe sganciate dai bombardieri tedeschi che invano tentano di arrestare quella marea che avanza, distintamente si sentono i lancinanti sibili degli Stukas14 in picchiata e lo scoppio tremendo di quelle grosse bombe che sganciano. Pare che anche la Divisione Sforzesca abbia subito la stessa sorte dell’Armata romena. Il nostro reggimento e il Sesto occupano ancora una piccola oasi di pace in un deserto di morte in cui si è trasformata tutta la grande ansa del Don.
Il dicembre è iniziato; fra pochi giorni arriverà il santo Natale, la festa più bella e desiderata dell’anno; Natale per tutti, e anche per noi. Brutte notizie giungono dal Comando di divisione; una parola terribile come la peste, più fredda dello stesso marosc che ha ripreso a soffiare, passa di bocca in bocca, da reparto a reparto: accerchiati. Sul fronte spezzato dei romeni e della Sforzesca, già da alcuni giorni le forze corazzate e motorizzate russe avanzano verso ovest e si dirigono a sud per tagliare i rifornimenti a Stalingrado e a nord per chiudere le nostre forze in un cerchio.
Le ventimila tonnellate e più di materiali e i quindicimila carri armati che gli americani hanno sbarcato per aiutare l’Armata Rossa cominciano a sortire effetti devastanti. L’obiettivo dell’avanzata russa è facilmente comprensibile a strateghi e non. Stalingrado vacilla; la battaglia che muterà le sorti della seconda guerra mondiale, la battaglia di Stalingrado, appunto, sta volgendo inesorabilmente al termine. Tedeschi e russi combattono di casa in casa; i morti si contano a migliaia; Von Paulus15 e la sua armata, per ordine di un altro caporale, pur privi di rifornimenti, di viveri, di tutto non possono arrendersi ma devono combattere fino all’ultimo uomo, morire tutti sul posto. Le nostre restanti divisioni, sempre saldamente attestate sul Don, rappresentano per il nemico una spina nel fianco ma non un grosso ostacolo, almeno per ora. Verranno eliminate a tempo debito e non con un attacco frontale, accerchiandole. Oggi tutto è chiaro; sul finire dell’anno 1942 molto meno.
È il dodici di dicembre; rapporto ufficiali. Il comandante della 2a Compagnia termina il rapporto dopo averci illustrato le ultime, tristi notizie apprese al Comando di reggimento. Accerchiati! Grave e preoccupante la situazione dei nostri reparti ma per ora l’ordine è di resistere sul posto, ad ogni costo. Ritorniamo fra i nostri bersaglieri muti, silenti ma non certo impauriti. Vedremo cosa ci riserverà il domani; d’altro canto anche lo scorso anno il 3° Bersaglieri fu per alcuni giorni accerchiato ma poi tutto finì nel migliore dei modi; un epico assalto alla baionetta infranse la morsa d’acciaio e il nostro reggimento riprese ad avanzare e a vincere.
Non nevica più; il vento ha spazzato le dense nubi; si rivedono in squarci di cielo le poche, scialbe stelle che brillano di luce fioca. Il solito lupo rompe il cupo silenzio col suo lamentoso ululato; il freddo è pungente; il suolo scricchiola ad ogni passo pesante o felpato. Mi sto dirigendo col fido Aleci all’osservatorio del mio plotone. Incontro e parlo col sergente Cappellaro che, seduto al suo posto di osservazione, pare proprio non essere interessato a tutto ciò che accade nelle vicinanze. È sempre calmo, sereno, saldo come è saldo il suo cuore di vecchio e provato combattente. Il pericolo non lo turba; di fronte al nemico sembra una quercia che non teme nemmeno gli uragani più violenti. È il vice comandante del mio plotone; i bersaglieri lo amano e lo rispettano; dietro di lui si sentono sicuri anche nella mischia più cruenta. È un bersagliere nato, un umile uomo ma di quelli veri che mai ho rivisto dopo l’assalto alla piazzaforte di Meskov. Che Iddio, un giorno, mi consenta di poterlo riabbracciare.
Mi siedo e il buon Aleci mi siede accanto invocando, com’è solito fare nel momento del bisogno, la solita “coccia di santo Donato”. Che silenzio dintorno! Un silenzio di tomba e di morte che avvolge gli uomini, le cose, tutto.
Guardo nel buio, in avanti, ma lo sguardo che penetra nelle tenebre e niente riesce a vedere più in là di un palmo di naso, non si ferma al grande fiume; no, no, va oltre, assai lontano, molto lontano. Non cerca nell’ombra il nemico in agguato; non scruta la steppa gelata; si perde nella scia dei ricordi e vede in una casa immensamente distante una mamma assorta in preghiere; un babbo severo che mal cela l’ansia opprimente e un piccolo fanciullo fratello che ignaro di tutto sogna beato in un caldo lettino. Quelle care visioni, quell’amato focolare si affacciano per un attimo alla vista, alla mente, nel cuore poi il tutto, così come è nato scompare nel niente del nulla. Maledetta la guerra, i caporali e i piccoli padri.
Accerchiati! Sono le due di notte e il termometro raggiunge i ventotto gradi, ma non fa un freddo eccessivo. Anche l’eco dei rimbombi lontani si è spento nella notte che dorme. Nei bunker, dove i bersaglieri non di turno riposano, c’è un dormiveglia e a momenti un sommesso vociare. Accerchiati! Qualcuno è pessimista; altri, forse per farsi coraggio, sostengono che anche questa volta, come in tante altre occasioni, riusciremo a farcela.
Stamattina è giunto l’ordine tassativo di risparmiare il più possibile le munizioni. Sparare solo su bersagli sicuri e quando non se ne può fare a meno; controllare le armi automatiche con raffiche brevi; viveri a metà razione per tutti, nessuno escluso. Nel caso che il nemico occupi Miklin e le vedette avvistino nuclei consistenti di forze avversarie sulla strada che collega il Comando di reggimento al Comando del XVIII Battaglione e di conseguenza si profili una minaccia di attacco alle spalle del Terzo, il XXV e il XX Battaglione, facendo perno nel punto di sutura col Diciottesimo, eseguiranno rispettivamente una conversione a destra e a sinistra e si attesteranno a difesa alla periferia di Migulinskaja che diverrà il nostro unico caposaldo.
Oggi è il 13 di dicembre, il giorno di santa Lucia; fra i miei monti si sostiene che è “il giorno più corto che ci sia”, ma in verità poi non lo è. La posta scritta una settimana fa è riuscita a partire per Millerovo; quella di ieri è stata invece distrutta al Comando di reggimento perché la strada per Meskov è stata interrotta dal nemico. La stessa cittadina di Meskov pare sia già saldamente in mano dei russi; del nostro Comando di divisione non abbiamo più notizie. Sono le 18 di sera e già le tenebre ricoprono con il loro cupo mantello tutto e tutti, anche i gravi eventi che stanno inesorabilmente maturando. Aspettiamo soltanto lo scontro che da un momento all’altro deve per forza avvenire; ci affaticano non il freddo pungente, non l’ansia dell’oscuro domani, tanto meno la paura dell’oggi incerto ma la sola, snervante attesa di qualcosa che deve succedere senza sapere ciò che sarà, né quando avverrà. Al comando di reggimento tentano disperatamente di ristabilire il contatto col comando di divisione, ma i tentativi sono vani, il radiotelegrafista, seduto al suo posto, batte e ribatte ancora il tasto dell’apparecchio; ogni tanto scuote la testa e sussurra: “niente, niente, non c’è niente da fare; sembrano spariti nel nulla”.
Un fatto nuovo, imprevedibile, forse più voluto dal fato che dal volere degli uomini, o viceversa, chissà, è accaduto alcuni giorni orsono ma soltanto stamattina la triste notizia è giunta ai reparti in un momento in cui di brutte notizie ne giungono anche troppe e sicuramente non concorrono e sostenere il morale e le coscienze degli uomini. La comunicazione che ci ci lascia esterrefatti, amareggiati, increduli passa da reparto a reparto come una folgore a ciel sereno, vola dalle retrovie alle trincee, dalle postazioni ai capisaldi avanzati e desta commenti vari, dispiacere certo. Il colonnello Felici, il comandante del 3° Reggimento Bersaglieri16, scendendo una scala pare sia caduto malamente ed abbia riportato lesioni a una costola. Infortunio sfortunato o fortunato, che comunque nella situazione in cui ci troviamo non ci voleva proprio. Il dottore l’ha fatto caricare su un nostro autocarro che subito è partito per Voroscilovgrad (o Millerovo) sperando di raggiungere l’ospedale attraverso qualche varco non ancora chiuso. Il colonnello Longo Luigi17, il vecchio e caro comandante dei reparti che, dopo l’addestramento in Italia, costituirono il Battaglione Complementi e vennero in Russia a colmare le gravi perdite subite dal Terzo, assume in queste ore gravi e solenni, terribili anche, il comando del reggimento più decorato d’Italia. È una vecchia conoscenza per molti ufficiali e per tanti bersaglieri, fortunatamente; è un comandante tutto di un pezzo; un vero comandante, degno del Terzo. Il cappotto grigioverde quasi sempre sbottonato che lascia vedere la bianca, calda pelliccia di agnello; la bustina con la visiera; l’inseparabile bastone; lo sguardo severo che nasconde un cuore generoso e forte; una calma invidiabile mai turbata né dalle bombe dei mortai o dalle infernali katiuscia18 o dal pauroso sferragliare dei grossi T-34 che fanno tremare il suolo; un coraggio che non conosce misura; di poche ma decise e sicure parole, ecco il nuovo comandante del reggimento. Il morale e la fiducia degli uomini, leggermente turbati dalla notizia dell’infortunio capitato al colonnello Felici, appresa la notizia della nuova nomina sono di nuovo alle stelle. Siamo tutti pronti a seguire il nuovo comandante dai nervi d’acciaio, quel temprato bersagliere che più che in ufficio abita fra i suoi ufficiali e coi suoi bersaglieri.
Alle ore venti un portaordini motociclista arriva trafelato al nostro Comando di compagnia annunciandoci, come di solito in questi giorni, spiacevoli avvenimenti. Gli autocarri, i nostri cari e inseparabili mezzi piumati, sono stati in parte distrutti da colonne motorizzate russe, in parte incendiati o resi inservibili dagli autieri. Si sono fermati per sempre, non hanno potuto raggiungerci perché accerchiati e in parte perché privi di benzina; son caduti sul posto. Ad uno soltanto è stato concesso il privilegio di osare di rompere il cerchio e puntare a sud-ovest; su quell’autocarro, dietro ordine del colonnello, sono saliti l’aiutante maggiore, due bersaglieri e i tesori più cari del reggimento: la bandiera del Terzo e il libro delle battaglie. Se riusciranno a mettersi in salvo, bene, altrimenti i custodi daranno fuoco ai due fusti di benzina e tutto brucerà nel rogo: tesori, autocarro ma non il loro ricordo che resterà perenne e immutabile.
Il morale dei combattenti, nonostante la gravità della situazione e l’incerto domani, è ancora alto; solo la calma e il silenzio che ci circondano irritano i già provati nervi. L’attesa di qualcosa che deve inevitabilmente accadere, ma che con certezza nessuno sa cosa sia, diventa spasmodica attesa.
Ore 22,15. Le mitragliatrici del I Plotone sgranano all’improvviso il loro sicuro rosario di morte; i fucili mitragliatori accompagnano col loro ritmico gracidare le sorelle maggiori; il ta-pum dei moschetti completa l’orchestra. Che sia iniziato l’attacco? E perché il caposaldo avanzato è silente? Ci precipitiamo attraverso i camminamenti dal III al I Plotone e le sentinelle, che già hanno dato l’allarme ai bunker, ci mettono al corrente della situazione. Ora anche il caposaldo avanzato si unisce al concerto; tutti i bersaglieri sono nelle trincee pronti a respingere il nemico. Dappertutto è una danza sinistra di lingue infuocate; è un accendersi continuo, davanti e dintorno, di mille fiammelle, di grosse scintille che per un attimo guizzano nel buio di una notte nera e poi si spengono per accenderne altre. Ogni tanto qualche tracciante scivola rossastra verso una meta invisibile e più che la coda di una cometa sembra una lucente girandola colorata che dritta squarcia il caleidoscopico turbinio di coriandoli volteggianti come in una folle notte di Carnevale. Coriandoli rossi di morte, girandole pure, non inni alla vita e all’amore. Ancora non è l’attacco finale; si tratta di una grossa infiltrazione di uomini tra la nostra linea e il caposaldo avanzato. Voci sommesse, scricchiolio metallico di neve calpestata, urla di rabbia e di dolore, si sono intesi dopo le prime raffiche sparate alla cieca dalle nostre postazioni verso la zona che destava preoccupazione.
Rapporto ufficiali al Comando di compagnia; è presente anche il comandante del XVIII Battaglione che manifesta preoccupazione per quella infiltrazione di forze nemiche nel tratto di fronte tenuto dalla 2a Compagnia. Ordine di servizio: una pattuglia di almeno dieci uomini e due ufficiali deve immediatamente perlustrare il terreno tra le nostre linee e il caposaldo avanzato; se non incontrerà russi dovrà spingersi fino al Don. Bisogna sapere con certezza se si è trattato delle solite, più numerose pattuglie esploranti o di forze nemiche che hanno attraversato il fiume per costituire una testa di ponte, preludio all’attacco che da tempo si aspetta. Il capitano Checchini ordina a me e a Spada di scegliere cinque bersaglieri ciascuno e di uscire per portare a termine la missione quanto prima possibile; i tenenti Puce19 e Romoli ci sostituiranno nei compiti d’ispezione. A mezzanotte e mezza la pattuglia uscirà in perlustrazione.
Ritorniamo ai reparti; abbiamo a disposizione una mezz’oretta per riposarci e pensare al dopo. Incontriamo Puce presso la piazzola centrale del suo plotone; ha la faccia rivolta verso il grande fiume e scruta nell’oscurità con gli occhi incollati al cannocchiale fregato ai russi; sta fermo e con la solita calma che non si scompone per nulla. Lo chiamiamo il Vecchio Meharista della Steppa, per gli interminabili episodi della guerra d’Africa che durante il riposo ci propina a piena bocca. È un combattente di antica data; non conosce la paura; non si allarma mai.
“Ciao, capo meharista del Sahara bianco, noi usciamo, capito?”
Senza scomporsi e continuando a guardare nel buio del niente, bofonchia: “Uscite davvero? Allora occhio alle piume ed anche alle penne; avvertirò immediatamente quelli del caposaldo e le sentinelle, va bene, burbe dal primo pelo?”
I bersaglieri che si sono offerti per l’azione di pattugliamento ci attendono alla postazione del II Plotone. Il fucile tra le mani, il tascapane a tracolla pieno di bombe, l’elmetto calato all’indietro per meglio vedere, la borraccia non più piena di cognac per combattere il freddo, che è tanto, attendono. Sembrano turisti in visita alle catacombe. Aleci è ritornato dal bunker con altri cinque caricatori per il mitra; dice che la voce di santo Donato gli ha sussurrato di rifornirsi ben bene e lui a quella coccia crede molto.
Guardo in faccia quei giovani che hanno ancora voglia di scherzare mentre aspettano l’ordine di uscire dalla trincea; cinque di loro sono del mio plotone, cinque di quello di Spada. Riconosco nel buio il volto quadrato di Sozzi, vedo i suoi occhi lucenti e severi che rispecchiano il coraggio e la spregiudicatezza che albergano nel suo cuore. Assomiglia stranamente al viso di quel bersagliere ignoto dipinto sulle cartoline che si vendevano allo spaccio delle caserme di Milano, di Lodi, di Besozzo e di Bolzano o alla effige della medaglia consegnata agli allievi, al termine del primo corso di guerra per ufficiali svoltosi a Pola. Vicino a lui siede Birelli, l’inseparabile amico, sicuramente a lui non secondo. Ecco poi il caporale Br*, tanto lavativo quanto audace, figlio della Calabria dalla quale ha ereditato il sangue generoso e forte che scorre nelle sue vene20. Aleci come sempre è al mio fianco e oltre a invocare il suo santo protettore, nei momenti gravissimi, ogni tanto esclama forte perché anche gli altri l’intendano: “se casca il mondo mi sposto un poco in là, cosi frego tutti, russi e paisa’” 21. Il quinto è il solitario R*, chiamato La Piccola Vedetta Lombarda per il coraggio, che rasenta l’incoscienza, dimostrato in più occasioni quando decide di scoprire ad ogni costo il luogo ove è appostato il nemico. Tutti, incuranti di qualche fucilata che possono buscarsi, sono seduti sul bordo della trincea in attesa della partenza e ridono al ricordo di passate avventure amorose. Umili, veri eroi senza medaglie e senza ricordo alcuno. Mi auguro che il Signore, quando mi accoglierà in cielo dove ogni essere umano deve per forza andare, prima di assegnarmi al paradiso o all’inferno mi conceda di rivedere, anche per un attimo solo, quei cari amici che il 21 dicembre del 1942 vidi per l’ultima volta prima dell’assalto alla cittadina fortificata di Meskov. Da allora mai li ho rivisti, né più niente ho saputo di loro; sempre, e finché la memoria non vacillerà del tutto, li ricorderò con l’affetto più caro, con vera amicizia, con l’ammirazione più grande.
Ore 24,30, si parte. Attraverseremo il reticolato nel punto F dove si trova un cavallo di Frisia e il maledetto campo minato; poi il fosso anticarro e se non incontreremo soldati russi sul terreno che separa la linea dal caposaldo del XXV Battaglione, ci spingeremo fino al grande fiume. Le bianche betulle e le grosse sterpaglie rinsecchite che crescono sulla terra di nessuno ci saranno amiche anche in questa occasione.
Il soffio delle sferzate del vento si mescola col cupo brontolio degli scoppi lontani che giungono dalla destra dello schieramento del Terzo. Il buio è sempre più buio; il tenue riverbero della neve ghiacciata ci consente di vedere all’intorno e ad alcuni metri di distanza; il suolo sul quale camminiamo con passi felpati scricchiola ugualmente come un vetro spezzato. Spruzzate di spilli gelati pungono la parte del viso scoperta dal passamontagna ad ogni ventata del freddo marosc che scende dal nord. Qualche rinseccolito arbusto che al nostro incedere si spezza, emette un sordo brusio che ci fa voltare di scatto e solleticare febbrilmente con l’indice il freddo grilletto delle armi. Siamo giunti senza incidenti al campo minato, potenziale nemico quanto i russi. I passi si fanno ancora più leggeri; par di camminare su una distesa di uova e se potessimo vincere la forza di gravità ci metteremmo volentieri a volare. Finisce l’incubo delle mine all’apparire del fosso anticarro; ora pare anche meno buio di prima. Ci fermiamo per riprendere fiato e la neve, sulla quale ci sdraiamo, sembra la coltre imbottita di letti lontani. Una lunga sorsata, meglio diverse sorsate di cognac attinte alle borracce ormai quasi vuote, ci ridanno forza, ristoro e calore; una sigaretta, tanto desiderata, resta invece nel pacchetto perché accenderla porta male.
E via, si riparte; ecco i tre alberi, il punto in cui le due squadre debbono dividersi: una a destra, l’altra a sinistra del caposaldo e verso est. Ci riuniremo al reticolato del fortino tedesco abbandonato: un fischio il segnale d’intesa; due, ricevuto. Una stretta di mano, un “boia di un Peppe” 22 e avanti per assolvere il compito assegnatoci.
Siamo nella terra di nessuno, al di là del caposaldo, che termina sulla riva destra del placido Don, la zona in cui tante volte le varie pattuglie esploranti di entrambe le forze si sono scontrate a suon di fucilate e di bombe a mano; ognuno con lo scopo precipuo di capire le intenzioni dell’avversario, l’entità delle truppe nemiche, soprattutto di catturare prigionieri per saperne di più. Al rimbombo degli scoppi ancora lontani, allo sferragliare dei T-34 e dei mezzi che attraverso i varchi sciamano verso ovest, a sud e a nord e che il vento ci porta all’orecchio, si aggiunge all’improvviso un altro frastuono che viene dall’alto. Sembra il rotolare sempre più assordante di una immensa valanga che scende dal monte e precipita a valle. Quel rumore di per sé già tremendo è violentato e sferzato a brevi intervalli da lancinanti ululati che ti spaccano i timpani, ti entrano in corpo e terminano con un boato spaventoso simile allo scoppio di un assopito vulcano che d’improvviso si desta. Sono loro, non ci sono dubbi, sono gli Stukas tedeschi che picchiano sulle colonne russe avanzanti.
Siamo fermi, immobili, attenti; non si può fare altro che guardare, nient’altro. Alle enormi vampate che si alzano da terra e squarciano il buio come i lampi in una afosa serata d’estate, si accendono in cielo altre fiammate anch’esse vivide e lucenti; sono gli scoppi dei proiettili della contraerea russa che a casaccio cerca quei falchi rapaci svolazzanti nell’aria. Le scie luminose delle traccianti fanno da steli a quei fiori di morte che sbocciano in alto. Sembra di assistere al gran finale di una serata di festa ricca di fuochi artificiali ormai all’ultimo atto. Dopo gli Stukas arrivano i bombardieri che sganciano non la sola bomba gigante dei primi, ma dieci, cento, mille bombe di peso minore ma per questo non meno efficaci di quelle. Cambia soltanto lo spartito musicale, ma la musica è sempre la stessa; dai colpi radi e possenti sulla grancassa si passa al rullio accelerato dei tamburi, ma è sempre fracasso. Non più uno scoppio tremendo e una uguale vampata qua e là, ma scoppi più numerosi e più fiammate rossastre le une vicine alle altre che comunque scuotono la terra all’intorno, che schiantano tutto, che sembrano l’accendersi di mille incendi che poi diventano un unico, grande falò; che paiono l’ira di Dio, il castigo, l’apocalisse, la morte.
Per circa mezz’ora continua quella sarabanda infernale poi, all’improvviso, così com’è nata si spegne e non resta più nulla all’infuori del buio che è sempre più buio. Si riparte e si giunge al caposaldo tedesco in attesa degli altri. Un fischio... due fischi... eccoli. Niente? Nulla di niente. E voi? Niente di nulla. Non ci resta che avanzare e cercare di raggiungere il fiume, il maestoso Don che ignaro di tutto e di tutti scorre placido e lento, o non scorre affatto, come si racconta in giro. Eccolo davanti a noi il grande corso d’acqua osannato, immortalato da eccelsi scrittori e da grandi poeti, amato da milioni e milioni di mugiki riconoscenti; un fiume con una imponente massa liquida torbida, almeno in questi mesi, che par più una immensa colata d’olio di semi di girasole per il colore giallognolo delle sue acque che si muovono tanto lentamente da celare alla vista più acuta dei curiosi la direzione stessa della corrente. Non è ancora del tutto ghiacciato ma immobile sta come la neve che cade, che cresce, che dondola solo al solletico di quelle folate di vento che giungono dal nord e che pungono la faccia come le foglie di ortica. Pare più un braccio del lago di Como che un grande, benefico, placido fiume; nient’altro.
Sfidai tempo fa il suo sacrale, casto pudore; volli accertarmi se quella enorme massa d’acqua scorreva o no; se la descritta immobilità, come quella di un lago, era solo finzione, geloso segreto della natura; se ciò che appariva anche all’occhio più attento altro non era che una fallacia evidenza dei sensi di chi lo ammirava, una impossibile eccezione alle regole del creato. E guardavo estasiato il placido Don di Šolochov, la steppa dintorno, le bianche betulle, le isbe dei mugiki, i campi di girasoli, il cielo scuro denso di nembi, la neve e il ghiaccio che stendevano una coltre ovattata su tutto e su tutti. Camminando, il ricordo dell’ultimo esame sostenuto all’università prima di partire per il fronte, l’esame di Lingua e letteratura russa, mi tornava alla mente. Che strano, misterioso paese la Russia! Così l’avevo immaginato, in questo modo definito, temuto. Usanze, costumi, vita, personaggi, lingua e letteratura, popoli di quell’immensa, sconosciuta terra ghiacciata erano entrati nella mia memoria solo per dovere di studio e di conoscenza, non certo per curiosità o interesse; anzi, con diffidenza e timore, mi ero convinto che appartenessero ad un mondo irreale, da favola, tanto diverso quanto infinitamente distante dal mondo reale in cui ero vissuto. E di quello strano mondo mi tornavano nella mente, in sequenze confuse Puškin e Gogol’, Tolstoj e Dostoevskij, Ševcenko e Cechov; poi gli ussari, i mugiki, i cosacchi del placido Don che i viaggiatori e gli esploratori medioevali ricordavano come Tanais di Novomoskovk, e i battellieri del Volga, altro grande, lentissimo fiume che in un tratto corre parallelo al Don e lo abbraccia con un grande canale, anch’esso “Lenin”, che Dio solo sa quante lacrime, sangue e vite era costato per costruirlo. E assieme a quei fantasmi ricordavo con chiarezza letture, poesie, e racconti ed opere che avevano destato in me riverenza, ammirazione, dubbi e timori: Le veglie alla fattoria di Dikanka, La tormenta di neve, Le anime morte, Guerra e pace, Anna Karenina e le musiche melodiose di Dargomyzskij23. Che buffa la vita! Ora vivevo in quel mondo irreale, di favola che avevo sognato, reso peraltro ancor più misterioso, più strano da nuove conoscenze di fatti, misfatti, personaggi e modi di vita impensabili nel nostro paese: i gaspodin e i tovarisc, il nacialnik e il commissario politico, la nomenklatura e la polizia politica, i bolscevichi e i trotzkisti, i menscevìchi e i buchariniani, i kolkosiani e i sovkosiani, le purghe e il terrore, la dittatura del proletariato e il partito dei lavoratori, i milioni di morti nei lager o nei campi di lavoro forzato nella invivibile Siberia, la Lubianka di Mosca e i manicomi per i dissidenti. Il desiderio non più di conoscere, ma di vedere, di toccare con mano, di vivere tutto ciò che mi circondava era grande, irrefrenabile, morboso. E il Don, il mitico Don mi stava di fronte. Lo avevo immaginato quel placido fiume come il nostro Po, più calmo, più maestoso, immenso e solenne, senza scatti d’ira, senza onde di piena. Guardandolo dalla balka di Kantamirovka, a due o trecento metri dalla riva destra, ad occhio nudo o col cannocchiale pareva, quell’immortalato corso d’acqua, soltanto un braccio del lago di Como, giallognolo e immobile, morto.
Fu in un insolito pomeriggio di un giorno qualunque del nebbioso, opaco mese di novembre, così mi par di ricordare, che volli vederlo da vicino, toccarlo, accertarmi senza ombra di dubbio se le sue acque, certamente profonde, con una enorme portata nell’alveo spazioso, scorrevano od erano ferme.
Quasi quasi, per soddisfare il desiderio di conoscere, ci rimettevo la pelle. Come e perché? Ecco cosa accadde per appagare la curiosità e l’interesse. Sulla terra di nessuno la nostra pattuglia, come i ladri di notte, andava in cerca di prede e per raggiungere un fine: accertare che truppe russe non si fossero attestate sulla sponda destra; catturare qualche prigioniero; individuare postazioni fisse per batterle con la nostra artiglieria. Un passo avanti e l’altro dietro, una zigzagante corsetta, una strisciata col corpo per terra, una sosta dietro ad una bianca betulla o ad un grosso cespuglio, sempre guardinghi, sospettosi di tutto, attenti ma senza eccessivi timori tentavamo con profitto di portare a termine la nostra missione. Eravamo giunti, risalendo un piccolo canalone del terreno defilato alla vista, al margine della radura che dopo un tratto di una cinquantina di metri lambiva l’acqua del fiume. Un tratto di terreno piatto, brullo e sabbioso con qualche grossa betulla sparsa qua e là, cresciuta dalla natura in ordine sparso. Probabilmente quel tratto di terreno, durante le grandi piene di primavera, diventava letto per le acque tracimanti dall’alveo naturale. Dal luogo ove finiva la boscaglia e sul quale ci eravamo sdraiati si distingueva anche ad occhio nudo la grande distesa d’acqua del Don che appariva immobile; non riuscivamo invece a scorgere la riva, il punto in cui l’acqua lambiva la terra per il fatto che la sponda e il terreno retrostante che ci separavano dal fiume erano di qualche metro più alti. La sponda, appunto, era simile ad un argine di un grande canale d’irrigazione e quindi ci consentiva di vedere dal posto di osservazione soltanto le acque ormai già profonde e che veramente sembravano immobili. Al di là del Don, anche la riva sinistra si ergeva di qualche metro sul letto del fiume e il terreno retrostante saliva dolcemente verso una linea di balke che finivano di confondersi col nebbioso e basso orizzonte.
Non si notavano in lontananza movimenti di uomini e mezzi; quei luoghi sembravano deserti, disabitati. Certo che quelle strane gobbe sporgenti alla rinfusa dal terreno non potevano essere uno scherzo bizzarro della steppa, né quelle ombre a mezzo busto e vaganti in quei solchi scavati di fresco nei campi dovevano confondersi coi fantasmi dei morti fuggiti dalle mura del Cremlino; no, no; erano le sentinelle russe che, come noi, vigilavano mentre il grosso della truppa riposava nei profondi bunker occultati alla vista. Una cosa era certa: il nemico non ci aveva ancora visto altrimenti, come di solito accadeva, ci avrebbe gettato addosso una tempesta di grandine rovente. Meglio così.
Visto che di russi non se ne erano visti in giro, il nostro piano d’azione prevedeva una sosta, in luogo sicuro e fino alle prime ombre della sera, allo scopo di poter individuare, con un po’ di fortuna, postazioni di armi sulle linee difensive avversarie. Stravaccato sul terreno cosparso di nevischio, di foglie secche e umidicce, era dolce il riposare; osservare poi non è un lavoro pesante; pareva di vivere per alcune ore in una felice oasi di pace. Con la testa eretta e mezzo busto pure, coi gomiti appoggiati sul terreno per tenere con le mani il cannocchiale incollato agli occhi, spaziavo con lo sguardo dalla radura all’immenso letto del fiume, risalivo la sponda opposta fino all’orizzonte in cui il plumbeo cielo toccava le balke. E nel riposo la mente e il pensiero, senza disturbare la vista, andavano oltre, lontani spaziando nell’orizzonte senza fine dell’immaginazione.
Nella posizione in cui mi ero disteso per meglio vedere e non essere visto provavo la stessa impressione di riposo e distensione che si avvertiva in caserma quando, vestiti, ci si accasciava sul pagliericcio della branda dopo una marcia di venti chilometri o una mezz’ora di corsa. Unico inconveniente: col passare del tempo s’indolenzivano i gomiti sui quali gravava il busto e un qualcosa di duro, celato alla vista dalla coltre nevosa mista a foglie cadute dalla berioska dietro alla quale stavo rintanato, mi procurava un fastidio al fianco destro e all’anca. Facendo leva sul gomito sinistro mi giro un po’ alzando di una spanna la parte dolente e con la mano che ha lasciato all’altra il cannocchiale annaspo tra il marciume gelato per togliere il non visto ma sentito intoppo. È un pezzo di ramo lungo una settantina di centimetri, grosso come il calcio del fucile, alquanto macerato dalla umidità ma con attorno qualche pezzo di bianca corteccia. È un comune pezzo di legno, ma il legno galleggia e il bianco ben si distingue sul colore giallognolo. Un lampo mi saetta in testa e mi trasporta veloce all’età della lontana fanciullezza quando, con gli amici del paese, andavamo a giocare sulle sassose rive del Reno. Lanciavamo nel letto del fiume, a monte del luogo prescelto come traguardo, in genere il Pozzone che si era formato davanti alla proprietà di Nuzzi, e in una zona dove l’acqua sembrava stagnare, dei pezzi di rami secchi raccolti sul greto, ivi depositati dalle ricorrenti, rabbiose piene che caratterizzano fiumi e torrenti di montagna i quali, ad ogni temporale, straripano e sradicano la ricca vegetazione che normalmente nasce rigogliosa sugli argini naturali per poi depositarla lungo il corso d’acqua. Vinceva chi per primo vedeva il suo pezzo di ramo tagliare il traguardo dal quale, tutti, avevano effettuato il lancio a monte. Sassi che interrompevano la corrente, mulinelli, gorghi, tratti stagnanti non dicevano niente; il vincitore era solo il più forte, nient’altro. Il Reno è un fiume e scorre e non cela a nessuno il suo andare; se il Don è un fiume deve fare lo stesso, non può stare immobile, no?
Ritorno con la mente alla realtà che mi circonda, a scrutare la radura che mi sta davanti, alla riva destra che non riesco a vedere, alla gran massa d’acqua che immobile divide noi dai russi, alla riva sinistra, alle balke e al cielo che nell’incipiente imbrunire si confonde con la stessa terra. La radura che ci separa dal Don, come ho detto, una cinquantina di metri di terreno piatto e brullo, è ricoperta da spruzzate di neve, erbacce secche e da uno strato di fogliame ai piedi di alcune grosse betulle sparse qua e là. È un tratto sabbioso, limaccioso con poche sterpaglie tutte piegate verso destra, cioè verso sud come se fossero state sbattute a terra dalle folate del gelido vento del nord. Non c’è dubbio che durante le grosse piene le acque fuoriescono dall’alveo e lambiscono a lungo la radura costringendo tutto ciò che incontrano ad inchinarsi alla grandezza e alla maestosità del placido Don. Otto alberi abbastanza grossi, cresciuti da madre natura in ordine sparso, a una decina di metri l’uno dall’altro, offrono un certo riparo a chi intendesse percorrere quel breve pianoro scoperto e di proprietà di nessuno, cioè di amici ed avversari. Addirittura due delle grosse betulle, distanti fra loro cinque o sei metri, si alzano dritte e imperterrite proprio sull’argine; quella alla mia sinistra è stata ferita dall’acqua sacra che, corrodendo a poco a poco l’argine scosceso, ha fatto franare in parte la terra scoprendo in tal modo alcune radici dell’albero che ora penzolano nel vuoto. Se l’acqua continua a rosicchiare la terra, prima o poi anche la betulla finirà per inchinarsi e rendere un ultimo omaggio al sacro fiume. Pensiero folle o incosciente pensiero? Zigzagando fra un albero e l’altro e infine acquattandomi dietro la betulla ferita riuscirò certamente a vedere la riva, il punto in cui l’acqua sfiora la terra; se poi getterò il pezzo di legno nell’alveo, a poca distanza, vedrò con certezza se le acque si muovono o se la diceria dell’immobilità è solo leggenda per riconoscenza verso un dono di Dio o della natura fatto a milioni di mugiki della grande, sconosciuta Russia. D’altronde anche il Piave è calmo e placido, ma ogni tanto mormora e va; questo non si vede né andare, né sbiascicare. Che strano però, ma poi mica tanto perché tutto è strano in questo più che strano paese!
Breve chiacchierata col collega e coi bersaglieri. Vogliono sapere dove sono ubicate le postazioni e i capisaldi nemici? Bene, ho trovato il modo per individuare i centri di fuoco avversari. Voi tenetevi, qualunque cosa succeda, occultati alla vista e sdraiati nel canalone; non rispondete al fuoco; copritevi le spalle e guardate costantemente la riva sinistra. Nient’altro. Nel caso in cui i Russi si accorgano di me e mi sparino addosso, visto che sta per scendere la sera, cercate di localizzare le fiammelle delle armi automatiche e individuare dei punti di riferimento sul terreno; sarebbe opportuno passare al colonnello De Simone, comandante del 120° Artiglieria, dati probanti per dare un saluto augurale a quei cari nemici. Di giorno, infatti, si odono gli spari, si sentono i proiettili arrivare ma non si riescono a vedere le lingue di fuoco vomitate dalle armi automatiche e non; ora invece che l’aria imbruna è un momento propizio. Lascio ad Aleci il binocolo e il tascapane, metto il mitra a tracolla, impugno il pezzo di ramo secco e parto; parto come partono i bersaglieri, di scatto, di corsa. Un albero e un tuffo per terra; un altro albero e di nuovo il solito tuffo; poi una breve sosta per riprendere fiato. Sembro una lepre che scappa in un campo di trifoglio inseguita da una muta di cani rabbiosi. E ancora a saetta, via. Altri tre tronchi per riparo e tre nuovi tuffi che mi indolenziscono ginocchi, gomiti e ventre. Le nocche delle dita che sorreggono il pezzo di legno e il palmo della mano libera usati come freno per attutire il tuffo, sono spelacchiati e mi bruciano molto. A una decina di metri, in avanti, c’è la grossa, alta betulla dalle radici in parte scoperte. Un po’ di riposo per il balzo finale.
Sono sdraiato dietro un tronco non troppo grosso; se sto ritto mi copre in gran parte il corpo, ma non del tutto; sdraiato come sono mi protegge gran parte del tronco ma non certo gli arti inferiori esposti ai proiettili sparati non di fronte, ma ai lati, in diagonale sia da destra che da sinistra. È una posizione scomoda, pericolosa; meglio scattare di nuovo per il balzo finale, e senza soste intermedie, stavolta. Mi restano ancora una diecina di metri e oramai il più è fatto - almeno così credo, ma invero non è. Del resto una volta presa una decisione da realizzarsi in una frazione di secondi, non si può modificare il piano, qualsiasi cosa imprevista capiti; fermarsi porta male, è pericoloso. Allora, via.
Ho fatto tre soli salti che d’improvviso sento attorno a me rumori di piccoli schiocchi come se mi avessero gettato addosso e intorno palate di ghiaia, pressappoco come quelle distribuite da Pierone e Tontino, stradini dell’Anas quando, al primo calar della neve o all’arrivo del gelo passavano su un autocarro, lungo la Statale n. 64, spargendo ritmicamente e a ventaglio badilate di ghiaino per evitare a persone e mezzi di scivolare sul manto della strada. Sono stato scoperto ma non ho tempo per pensare a soluzioni diverse da quella progettata; vedo soltanto la betulla e nient’altro. Ancora due salti e poi un gran tuffo a corpo morto per terra. Sono letteralmente appiccicato al terreno come a scavarlo; niente guai, soltanto un dolore attorno al capo e molto fastidio al ventre arrecatomi dalla solenne spanciata, che quasi mi ha tolto il fiato. La velocità della corsa, nonostante la brusca frenata, è stata così elevata che non si è esaurita all’impatto col terreno ma allo sbattere dell’elmetto, col resto dentro, contro la dura corteccia del tronco.
Che botta, quella botta, popolo! Generalmente l’elmetto cinge la testa due dita sopra gli occhi e circa tre centimetri dall’attacco al cranio dei padiglioni auricolari. L’urto contro l’albero me lo ha calato sul capo oltre misura e il bordo inferiore di cuoio, che ricopre l’acciaio, mi ha premuto con forza sull’intera circonferenza occipito-parietale e frontale procurandomi, oltre al forte dolore, anche un non indifferente disturbo. Infatti tanto è calato sugli occhi, quel cappello di ferro gelato, che non riesco a vedere a un palmo dal naso. E la ghiaia continua a cadere dintorno con ritmo crescente.
Mi sembra di essere sdraiato nella soffitta di casa mia quando, alla ricerca di cianfrusaglie che in genere si scoprono in ogni soffitta che si rispetti, anche se molto bassa, scoppiava in cielo un temporale. L’acqua iniziava a picchiare argentina sulle tegole vecchie del tetto poi, qua e là, si udivano distinti i primi tonfi dei chicchi di grandine che aumentavano d’intensità rapidamente e trasformavano il ticchettio, anche piacevole, delle gocce in un frastuono assordante, da far paura, a quei tempi. Così è tutt’intorno a me. Uno sforzo per riportare nella posizione primitiva l’elmetto, poi la vista si allarga d’incanto davanti, a destra, a sinistra, dove gli occhi vogliono guardare. Vedo distintamente sulla riva sinistra accendersi dieci, cento fiammelle infuocate rese scialbe dal chiarore, seppur tenue, che ancora rimane prima del buio; odo il rumore dei colpi o delle raffiche che seguono le vampate mentre le vivide lingue rossastre delle traccianti si spengono vicino, dietro, sopra di me. Il tronco mi pare che diventi sempre più piccolo, il mio corpo ogni minuto più grande. Nessuno parla vicino; la costa deserta e lontana è un luccichio che si estende a destra e a sinistra; par di guardare un lungo cimitero alla sera del giorno dei morti. E sparano ancora e molto intensamente.
Tra lo spruzzo sollevato dai proiettili che si conficcano nel terreno circostante, e che non fanno eccessivo rumore, riesco ad udire un leggero fruscio sotto di me, sotto la sponda scoscesa; sì, è l’acqua che scorre, è l’acqua del placido Don e la sento, la vedo, si vede perdiana. Due o tre colpi secchi sul tronco smorzano, ma non del tutto, il mio entusiasmo; quelli che sollevano spruzzi vicino sono ormai familiari e poi non fanno male. Il braccio destro è disteso, come il resto del corpo, e appiccicato al fianco; alla vista dell’acqua si scolla d’incanto e roteando a semicerchio scaglia, senza un preciso impulso cerebrale voluto, ma come movimento riflesso, il bastone rinsecchito a pochi metri dalla riva, in avanti, sul liquido giallognolo che si perde in lontananza. Lo vedo cadere, sollevare uno spruzzo, affondare, sparire alla vista, riemergere e lentamente, lentamente spostarsi verso la mia destra, verso sud, non cullato dalle onde che non si vedono affatto ma trasportato dalla enorme massa d’acqua che si muove, che va, anche se piano piano verso la foce, verso la meta, in questo caso mille miglia distante, che madre natura ha assegnato a tutti i fiumi del creato, verso il mare.
Che delusione, però! E non c’è leggenda o miracolo nella lentezza di questo grande fiume, lentezza che non è immobilità. La grande massa d’acqua scorre lentamente, adagio, con un movimento quasi impercettibile per il semplice fatto che quel lungo corso d’acqua, dalla sorgente dove nasce, il Rialto Centrale (circa 300 metri di altezza), dopo un viaggio di oltre tremila chilometri, si getta nel mare (il mare d’Azov) scorrendo su un terreno talmente pianeggiante che rende insignificante il dislivello da superare e quasi nulla la velocità di corrente.
Scendono le ombre della sera seguite dal primo, timido buio. Gli spari si fanno isolati e poi, come sono iniziati, cessano del tutto. Strisciando sui ginocchi e sui gomiti ripercorro il cammino a ritroso e dopo poco mi ritrovo tra i miei bersaglieri. Una stretta di mano e via, verso il rientro alla base, al sicuro. Il fido Aleci mi prende sottobraccio e mi assicura che durante il temporale ha rivolto un fervido pensiero alla “coccia di santo Donato”; con l’aiuto del Protettore e con molto di dietro è andata bene davanti.
La sera stessa, mentre sul ruvido tavolaccio godevo un meritato, breve riposo, riandavo con la mente all’esame di Lingua e letteratura russa, al mitico, solenne e maestoso fiume della steppa infinita che è tutto, sì, ma è pur sempre e soltanto un grande, lungo fiume come tutti i grandi, lunghi fiumi del mondo, nient’altro.
Lascio i ricordi e rientro nella cruda realtà del servizio di pattuglia che stiamo effettuando. Procediamo guardinghi e lentamente lungo il canalone che porta alla radura antistante il fiume. Quattro bersaglieri ai lati, due a destra e due a sinistra sul tratturo sopraelevato rispetto al sentiero che percorriamo, ci proteggono i fianchi. Ad un tratto, improvvisamente, ad una cinquantina di metri e sul lato sinistro, s’odono alcuni scoppi, poi altri seguiti da raffiche di parabellum russi. È senz’altro una pattuglia nemica che più che vederci ha udito il rumore dei nostri passi. Fiammelle che nascono, si spengono e si moltiplicano; silenzi profondi, pensieri che salgono al cielo, speranza in tutti di farcela.
A terra ragazzi; e le dita ormai stanche di stare poggiate sui freddi grilletti delle armi gelate, bagnate dalla neve che scende si contraggono inviando al nemico lo stesso saluto augurale che ci ha rivolto. Cerchiamo un riparo e strisciando per terra annaspiamo tra le neve per trovare un sasso o qualcosa a difesa.
Ora anche sulla nostra destra, e non troppo distante, si accendono altre fiammelle che non sono fuochi fatui rubati dal vento in un cimitero, son raffiche, colpi di fucile sparati dai soldati russi che tentano di accerchiarci. Par proprio di essere in chiesa in un giorno di festa: un altare alla destra, un altro a sinistra e nel mezzo, nella navata centrale, nell’abside forse, noi che accendiamo altri ceri pregando il buon Dio che mai ce li spenga. Quattro di noi sparano da una parte, altri quattro dall’altra e i restanti dove s’accendono all’improvviso le guizzanti fiammelle. Occhio ragazzi e fuoco d’inferno; c’è come posta la pelle e a morire c’è tempo domani; quelli vogliono tagliarci la strada verso il nostro caposaldo e pertanto non ci resta che una cosa da fare e con fretta: sloggiare, sganciarsi e cercar di passare tra i due centri di fuoco, e sperare.
Pronti? Via, fuori le bombe a mano e di corsa verso il canalone dove ancora, con un po’ di fortuna, possiamo passare. Un soffocato gemito, che è più una solenne imprecazione che un urlo di dolore, s’alza vicino.
“Coraggio, amico”, e ordino ad Aleci di prendere in spalla il caporale ferito.
Un proiettile gli ha forato il polpaccio; perde sangue ma si tratta di una ferita leggera. Aiuto l’attendente a caricarsi sulle spalle il bersagliere; riprendo da terra il mitra ma la canna è talmente rovente che solo afferrando il lungo caricatore o il calcio di legno è possibile recuperarlo.
Avanzando e lanciando si superano una ventina di metri, poi un altro gemito: un secondo soldato è stato colpito a una spalla. Riesce a muovere la mano e il braccio; il proiettile non dovrebbe aver leso l’osso o l’articolazione; riesce a camminare da solo. Sozzi prende in spalla il caporale per far riprendere fiato ad Aleci.
Strappiamo con rabbia le linguette di gomma delle bombe e tutti assieme lanciamo sia a destra che a sinistra e in avanti. Quasi contemporaneamente una decina di scoppi, di vampate, un fracasso tremendo tolgono ai russi la voglia di chiuderci la strada verso casa. Spariamo e lanciamo; tra un lancio e uno scoppio, curvi avanziamo al tenue riverbero della neve che c’impedisce di sbattere contro qualche ostacolo imprevisto. Udiamo altre grida, un vociare sommesso distante, rumori di passi non più tanto felpati. Chi spara e chi spera, chi scivola e chi cade, chi arranca e chi cerca di affrettare l’incedere sul difficile terreno ghiacciato e innevato. Sozzi ha caricato sulle spalle di Birelli il caporale ferito. È sudato come una bestia ed ansima come un mantice ma i due bersaglieri colpiti, ben protetti al centro del gruppo, rientrano alla base assieme a tutti noi.
Ormai ci siamo sganciati dai russi; nessuno c’insegue e ritorna dintorno il silenzio e la pace. Siamo di nuovo nelle nostre trincee; vado con Spada a rapporto dal comandante di compagnia:
“Scontro severo con due pattuglie nemiche; due feriti leggeri; tutti rientrati; l’entità delle forze avversarie al di qua del Don limitata a due gruppi esploranti. Nient’altro signor capitano”.
Avviso ai naviganti
Questo è il sito della
Associazione Culturale
il Mascellaro
Associazione Culturale
il Mascellaro
| • | Per visionare i nostri libri cliccare qui |
| • | Per leggere altri libri consultabili cliccare qui |
| • | Per andare sul sito Miradouro / mascellaro.it cliccate qui |